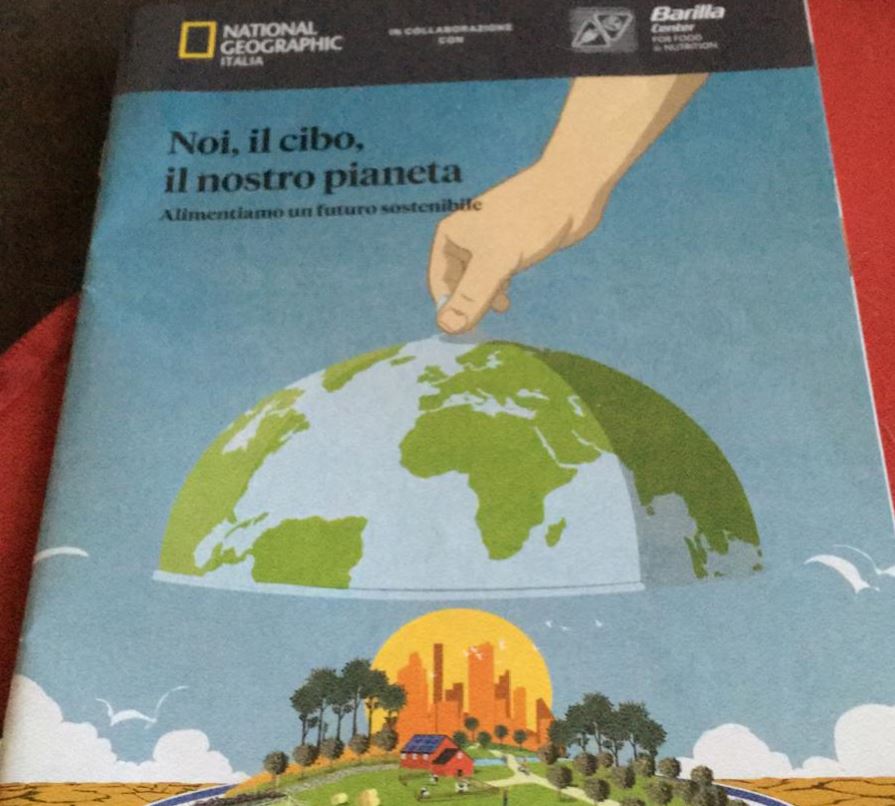
L’innovazione è destinata a volare nei campi con i droni, per fornire indicazioni in tempo reale su come mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici. Penetrerà nei suoli, per rigenerarli, con l’aiuto di ecologia e scienze agrarie. Germoglierà dentro ai semi geneticamente corretti per resistere meglio a malattie e siccità. Ma dovrà essere anche innovazione sociale, per armonizzare le politiche pubbliche che seguono il cibo dalla terra alla tavola, evitare gli sprechi, rendere le nuove conoscenze accessibili a tutti.
Se c’è un messaggio che emerge forte e chiaro interpellando gli esperti, e leggendo il primo rapporto su clima e terra pubblicato dall’IPCC nell’agosto del 2019, è proprio questo: la sfida per nutrire il mondo nell’era del riscaldamento globale è troppo complessa per illudersi che esista un’unica soluzione tecnologica buona per tutte le occasioni.
“La ricetta per l’agricoltura sostenibile è in continua evoluzione, e questo è un bene. Agricoltori, consumatori, imprenditori, politici e scienziati continuano ad apprendere cose nuove su quali sono i modi migliori per nutrire l’umanità, proteggere le risorse naturali, aumentare i redditi”, ci dice Danielle Nierenberg, presidente della ong-pensatoio Foodtank.
La lezione che stiamo imparando è che le conoscenze tradizionali non sono alternative ma complementari alle ricerche di frontiera. L’hitech deve andare mano nella mano con il lowtech. Le coltivazioni intensive che hanno il pregio di evitare la messa a coltura di nuovi terreni devono coesistere con le coltivazioni estensive che hanno il merito di recuperare la fertilità nelle aree sovrasfruttate. La parola d’ordine è contaminazione, non più dell’ambiente ma delle idee.
Gli ingredienti della ricetta per la sostenibilità sono tanti e possono essere combinati in più modi. C’è l’irrigazione smart che consente “more crop per drop”, maggiore raccolto per goccia. Ci sono i sensori per ridurre al minimo indispensabile input chimici ed inquinamento. Abbiamo le biotecnologie di nuova generazione come l’editing, che mira a riprodurre con precisione scientifica le mutazioni utili che avvengono casualmente in natura, senza bisogno di inserire DNA estraneo. Ma nei disciplinari si fanno largo anche i mix di sementi antiche e convenzionali, la cui biodiversità consente di utilizzare al meglio le risorse naturali esplorando il terreno a livelli differenti. E sempre per ripristinare la salute dei suoli, si studia come integrare al meglio la coltivazione di specie perenni e annuali.
L’elenco dei filoni di ricerca a cui si dedicano ingegneri e genetisti, agronomi e naturalisti potrebbe continuare. Basta variare un po’ le combinazioni per ottenere soluzioni più o meno adatte a questo o a quel contesto climatico, ecologico, economico e sociale. Possiamo chiamarle agricoltura a intensificazione sostenibile, climaticamente intelligente, rigenerativa, conservativa, agroecologica. Tutte queste varianti hanno vantaggi e limiti.
L’agroecologia, in particolare, nasce per applicare i concetti ecologici all’agricoltura e si presenta con una triplice polarità, come ci spiega Luca Colombo, segretario generale della Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica. “È una disciplina scientifica, un insieme di pratiche agricole e un movimento sociale”. Come approccio è molto in voga nel comparto organico ma ambisce a sconfinare sempre più spesso al di fuori del perimetro bio. Non si dà come primo obiettivo la massimizzazione delle rese, è ad alta intensità di manodopera ma anche di conoscenza.
“Non pone il baricentro in un determinato pacchetto tecnologico, ma le tecnologie compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ecologica e sociale sono ben accette. Non è certo l’agricoltura del nonno”, commenta Colombo. Aprirà le porte anche alle sementi geneticamente corrette con l’editing? Per ora l’argomento non è in cima all’agenda, fa il punto Colombo di ritorno dal convegno sull’agroecologia che si è tenuto a Creta a settembre.
“In quanto nerd dell’agricoltura sono entusiasta delle potenzialità tecnologiche, ma mi chiedo: chi ne trarrà beneficio?”, ci dice Nierenberg che negli ultimi anni ha intervistato centinaia di operatori ed esperti in oltre 50 paesi tra Africa sub-sahariana, Asia e America Latina. Se l’editing genomico, con la tecnologia CRISPR in testa, venisse usato solo per le materie prime e per i tratti di interesse industriale, come è accaduto con gli OGM, sarebbe un vero peccato.
“Spero che si lavori sulle specie importanti per l’alimentazione, buone per le persone e per il pianeta, compresi i grani perenni ad elevato contenuto proteico, sorgo e miglio, ortaggi e frutti nutrienti e altro ancora”. Il cambiamento del clima richiederà piante capaci di tollerare meglio gli stress abiotici e modificherà la geografia dei patogeni. L’editing, dunque, è chiamato ad affrontare anche il problema della resistenza alle malattie.
Kevin Pixley dirige un progetto contro la necrosi letale del mais presso un grande centro di ricerca no-profit, il Cimmyt, e anche lui auspica per la ricerca genetica “nuovi approcci, con un’accresciuta integrazione con le prospettive agroecologiche e maggiore considerazione dei contesti sociali”. Nell’articolo che ha pubblicato recentemente su Annual Review of Phytopathology, passa in rassegna i problemi potenzialmente risolvibili con l’editing genetico, concludendo che gli ostacoli maggiori sono politici e non scientifici. A cominciare dal disinvestimento pubblico in ricerca e sviluppo per l’agricoltura, che fa pendere la bilancia dalla parte delle grandi industrie private.
Andrea Renda, del think tank CEPS, è un esperto di innovazione e policy-making che lavora con le istituzioni europee ed è convinto del potenziale delle nuove biotecnologie per il futuro dell’agroalimentare, ma ritiene che sarà necessario un “grande sforzo, per ristabilire la fiducia nella scienza” dopo tanti anni di controversie. Il suo principale interesse sono le tecnologie digitali, che presentano problemi altrettanto e forse ancora più spinosi di equità e trasparenza. “Le grandi piattaforme, come Google o Ibm, possono arrivare a dominare il comparto agricolo, perché sono in grado di disseminare i campi di sensori e poi di gestire la mole di dati che verranno prodotti in quella che chiamiamo internet delle cose. Il grande valore in agricoltura come negli altri settori, negli anni a venire, sarà nei dati”, sostiene Renda.
La scienza da sola non basta, le innovazioni devono trovare un ecosistema sociale che le accolga per potersi diffondere. Che ruolo può svolgere il policy-making per favorire la sostenibilità dell’agricoltura? “C’è bisogno di regolazioni di settore che creino incentivi per gli operatori a trasformare il proprio modello di business rendendolo più sostenibile; ma prima ancora c’è bisogno di coerenza tra le politiche pubbliche che spingono in direzioni diverse”, ci dice l’esperto. “Altrimenti predichiamo sviluppo sostenibile e razzoliamo efficienza economica”.
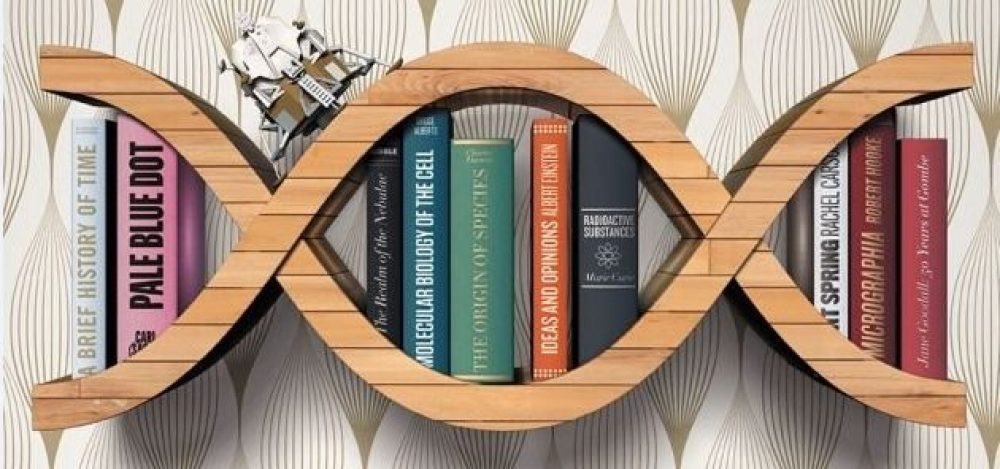
In molti forum, sento spesso parlare di sementi antiche e ancora più spesso di grani antichi ma mi resta difficile comprendere di cosa si intenda quando si fa uso di questi termini. Una spiegazione sarebbe gradita. Grazie
"Mi piace""Mi piace"
si tratta di varietà sviluppate decenni fa, che non sarebbero più competitive sul mercato dal punto di vista delle performance ma vengono riprese per ragioni “culturali”, ad esempio il senatore Cappelli https://it.wikipedia.org/wiki/Cappelli_(frumento)
"Mi piace""Mi piace"
Gentile Dott.ssa Anna Meldolesi grazie della risposta.
Immaginavo che l’esempio finale alla mia domanda sarebbe stato la varietà di grano duro “Cappelli”; tuttavia, non comprendo le ragioni “culturali” da lei menzionate per giustificarne la coltivazione, peraltro mai interrotta dal 1915 ad oggi. E’ vero che tale coltivazione, con l’introduzione dei grani a taglia bassa, sia rimasta ristretta a zone piuttosto limitate e solo negli ultimi anni si sia ampliata.
La ringrazio per l’attenzione, ma non credo abbia risposto in modo adeguato alla mia precedente domanda.
PS: Un consiglio, io è la prima volta che partecipo ad un forum e non credo che citare wikipedia sia un buona idea.
"Mi piace""Mi piace"